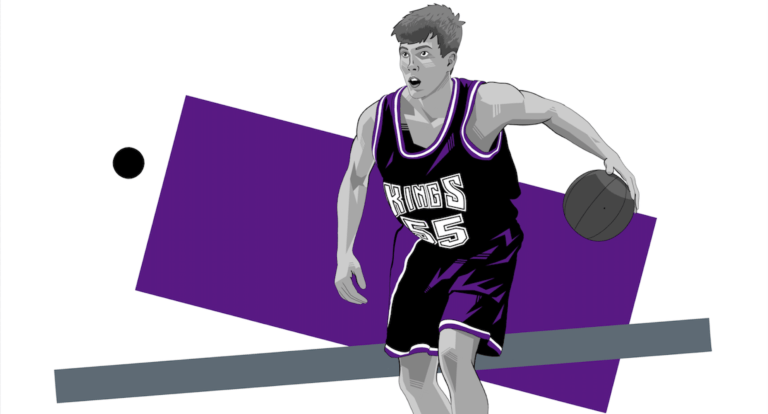di Emanuele Venturoli
disegno/copertina di Valerio Torzani
Un uomo se ne sta seduto su una panchina a Blue Jacket Park. Il suo corpo è compresso dalle spalle larghe di un gruppetto di ragazzi seduti sullo stesso asse di legno. Anche i ragazzi hanno il mento appoggiato nell’incavo delle mani e lo sguardo fisso in avanti. Come l’uomo, sono in perfetto silenzio. L’uomo ha parcheggiato la macchina fra Lower Park e General Rees e ha attraversato i due diamanti da baseball dei NOK Little League, in direzione della scuola, la Escuela de Ivana Glenridge Middle School. È solo un altro mercoledì sera qualunque di una settimana qualunque a Orlando, Florida: tanto vale fare due passi, si era detto. Ora però se ne sta seduto sulla panchina da venti minuti, guardando confuso il rettangolo di cemento verde scuro su cui corrono dieci ragazzi con un pallone. Poi prende il telefono e compone un numero.
“Sì?”
“Senti, devi venire giù al parco. C’è un tizio che sta facendo delle cose incredibili con la palla. Ci saranno duecento persone a guardare una partita del cazzo qualunque, e ne arrivano altre”
“Descrivilo”
“Non troppo alto, un po’ appesantito ma non grasso. Capelli corti sui lati. Avrà circa trentacinque, quarant’anni”
“Aspetta, è bianco?”
“Sì, è bianco”
“Bene. Il ragazzo è tornato in città”
Raramente nella storia della pallacanestro moderna l’analisi di un giocatore ha tanto necessitato di scomodare la tricotomia Kantiana fra vero, bello e sublime come nel caso di Jason Williams. Come nella triplice essenza del filosofo di Konigsberg, anche il pubblico del playmaker da Florida si può suddividere in tre macrocategorie: chi ha visto in lui uno dei più grandi interpreti della palla a spicchi di sempre, chi lo ha odiato per la orrida futilità del suo gioco e infine l’onnipresente corrente democristiana che, dati alla mano, non scorge altro se non una point guard dalle statistiche decisamente mediocri in un’epoca di meravigliosi primi violini del playmaking. Tutto questo, ovviamente, è vero e falso allo stesso tempo e proprio per questo dannatamente difficile da comprendere.
Sipario. Il tempo è l’indicativo presente. I colori che inondando l’obiettivo sono il verde dell’erba e il grigio dell’asfalto. La storia di Williams comincia a Belle, West Virginia, uno di quei posti che tutti dovrebbero vedere almeno una volta nella vita prima di commentare con ostentata sicurezza un qualsivoglia exit poll elettorale statunitense. Belle, 1250 anime arrotondando per eccesso e se si conta il distributore con ammezzato abitabile in fondo alla strada, se ne sta oziosa sulle rive del Kanawha River, un tributario dell’Ohio dalle acque non precisamente cristalline. Il padre di Jason, pseudo militare congedato, è il responsabile della sicurezza nella scuola e del paese. Scuola e palestra di cui, manco a dirlo, possiede le chiavi. Pragmaticamente, le storie del Giasone cestista e dell’uomo Williams partono da qui, ognuna con premesse che sono largamente diverse.
Come spesso accade nelle massime leghe sportive, infatti, è complicato sovrapporre la traiettoria del giocatore e il luogo geometrico dei punti percorsi dall’uomo. Da un lato, quando le due gaussiane si toccano -raramente a dir il vero- nascono i punti chiave di un playmaker spettacolare che ha fatto impazzire una generazione intera e che, in fin dei conti, ha pure vinto un titolo. Ma quando i due grafici non collidono, allora ne esce lo stridore tipico del gesso sulla lavagna: i problemi di droga al college e quelle tre famose parole rilasciate in diretta nazionale dopo una sconfitta con la maglia di Memphis, “this team sucks”.
Di Belle, West Virginia, Williams si è portato dietro il provincialismo poverello e un po’ arrogante che una volta veniva definito tipico del white trash. È sufficiente vedere il video girato nella sua mansion di Memphis -una enorme villa in marmo rosa all’interno della quale Williams ciondola in ciabatte, cappello all’indietro e stuzzicadenti in bocca mentre i cani sguazzano nella Jacuzzi- per ricordare quel detto, secondo cui si può togliere il ragazzino dalla provincia, ma non la provincia dal ragazzino.
Parimenti però, in un gioco di specchi deformanti, dalla Virginia dell’Ovest e dalla palestra di cui il padre ha le chiavi, Jason porta con sé anche una confidenza con il pallone raramente vista su un parquet e un concetto di gioco tutto suo, in cui un passaggio dietro la schiena vale più di due punti e in cui l’assist no look merita più replay della schiacciata che lo segue. Capita, quando per quattro ore al giorno l’unico a cui passare la palla è un muro. Nel fagotto con cui uscirà dal paesello, inoltre, abbondano la sicumera e la spavalderia necessarie per andare a fare accademia con champagne e aragosta nella lega professionistica più severa del mondo.
Il primo approccio con lo sport semiserio del Giasone da Belle è all’high school di Dupont, cinque miglia da Charleston. Più che dal programma educativo del liceo, l’attenzione del giovane Jason viene catturata dall’ampia scelta sportiva dell’istituto e da un compagno di classe dal carattere altrettanto vispo e problematico: Randy Moss. Sia “vispo” che “problematico” vengano qui interpretati in senso ampiamente eufemistico. Futuro pretendente alla Hall of Fame del football NFL e punto cardinale più settentrionale di un attacco -quello dei Minnesota Vikings– che ha fatto impazzire una mezza generazione di tifosi, Moss sarà per Williams uno straordinario compagno di giochi, sia in ambiti più regolamentati (nel basket, nel football e nell’atletica, di cui Moss detiene a tutt’oggi il record statale nei 100 e 200 piani), sia in territori dai confini più grigi (corse con auto non esattamente di proprietà e consumo di sostanze non rigidamente OTC). Ironia della sorte vorrà proprio che la carriera dello stesso Moss inizi a traballare per i succitati motivi. Nel 2004, da giocatore proprio dei Vikings, investirà con la macchina un agente delle forze di polizia di Minneapolis e nel suo baule verranno trovati diversi etti di marijuana.
“Agente, ma questa macchina non è neanche mia”
“Signor Moss, lo dice come se non fosse un problema”
Yearbook a parte, i risultati sportivi eccellenti al liceo hanno l’effetto di intasare la buchetta della posta dei Signori Williams con innumerevoli lettere dei migliori college americani. Jason opta per Providence, poi ripiega su Clemson, infine decide per la Fork Union Military Academy of Virginia. Quando arriva alla FUMAV, la prima cosa che gli viene messa sul tavolo è un essay di inglese di 500 parole da completare in trenta minuti. Al secondo giro di lancette, il ragazzo è fuori dalla porta. È dunque il turno di Marshall, un college di seconda divisione in Virginia dove Williams incontra Coach Donovan. È proprio Donovan a portarlo a quella University of Florida dove diverrà una sensazione nazionale e a metterlo sulla mappa mondiale della palla a spicchi.
Nella stagione 1997-98 con i Gators J-Will viaggia a 17+7 ad allacciata, aggiungendo al bottino la consueta pletora di dietro la schiena, crossover e no-look. È uno dei momenti più alti della sua carriera cestistica: Williams è la “next big thing” del basket, le sue foto appaiono in copertina su diverse riviste specializzate, la maglia col coccodrillo va a ruba e i primi paragoni con un altro SEC, Pete Maravich, iniziano ad essere scomodati. Dal campus di Gainesville, e con la forza di un temporale estivo, la popolarità di questo ragazzino bianco divora l’America: è il pandemonio.
All’apice di questa esplosione, come nelle favole, arriva la mezzanotte e la carrozza diviene zucca, la scarpetta pantofola bagnata e i cavalli bianchi topolini con la rabbia e i denti storti. Per la seconda volta viene beccato a consumare droga, escluso dalla squadra e cacciato dal college. A 22 anni, senza uno straccio di educazione e con una fedina penale che inizia ad essere logora come un lenzuolo vecchio, Williams si autodichiara eleggibile per il draft NBA.
Viene scelto settimo in assoluto dai Sacramento Kings in un draft a dir poco discreto che vedrà protagonisti, fra gli altri, Bibby, Carter, Jamison, Nowitzki, Pierce, Rashard Lewis e quel Raef LaFrentz che entrerà nei manuali di basket per sempre come l’uomo capace di concludere goffamente il passaggio con il gomito di Williams all’all-star game dell’anno successivo.
Il draft si tiene ad Orlando, Florida, città in cui inizia e in cui finisce la nostra storia, e in cui si narra di una partitella memorabile a cui partecipano, oltre a Williams, anche Shaquille O’Neal e Anfernee “Penny” Hardaway. Chi c’era, come sempre pochi e senza nomi, dice che uno abbia palleggiato in testa all’altro e che da qui ne sia scaturito un alterco non esattamente da Sala della Pallacorda parigina. Decidete voi come attribuire le parti.
A Sacramento, Williams spende i primi tre anni di carriera NBA, quelli a cavallo del 2000. Sono forse i più belli, e anche quelli che tutti ricordano, complice ovviamente una squadra che gioca un basket anarchico e poetico, senza lingua, senza playbook e senza ruoli. Webber è un maestro di Cerimonia atipico, mentre Stojakovic, Christie e Divac stanno all’improvvisazione della pallacanestro come Gordon Ramsey sta alle uova strapazzate.

L’Arco Arena è un pandemonio sera dopo sera e, mentre la divisa dei Kings viene venduta a ritmi da Crispy McBacon, i video e i recap della Lega si riempiono di no look, alley oop e transizioni in cui chiunque se la passa dietro la schiena, sotto le gambe, ad occhi chiusi.
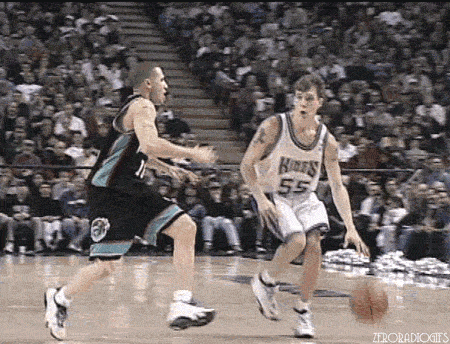
Bob Ryan del Boston Globe, il 31 Dicembre dello stesso anno scriverà: “I Kings sono qui a ricordarci i momenti migliori di questo sport. Qualcuno dovrebbe mandare un video delle loro partite in tutti quei posti, quelle palestre e quegli uffici grazie ai quali la passione e il divertimento sono scomparsi dal gioco del basket”. Online i tifosi della capitale della California vendono felpe e maglie con la scritta “We’ll see you on every highlight reel in America”.
Come in ogni documentario sulle primavere russe però, nei play-off del 2001 la perestroika nero-viola si stampa contro la pragmaticità devastante dei Lakers di Kobe e Shaq. Dopo un turno vittorioso contro i Suns, i Kings e Williams vengono liquidati 4-0 dai gialloviola. È una serie che la dice lunga su quello che succede quando il “baloncesto bailado” incontra il deforestamento cestistico che sono i Lakers di quegli anni: gara 3 in particolare, giocata all’Arco Arena, decreta un -22 che gronda sangue e non necessita di ulteriori appelli. Il nostro uomo dalla Virginia in quella gara gioca 21 minuti, totalizzando 2 punti, uno su otto al tiro, quattro assist e quattro palloni regalati agli altri. Non abbastanza, decisamente non abbastanza.
Per la dirigenza è ora di cambiamenti e Williams viene ceduto in cambio di Mike Bibby, un playmaker molto più sostanzioso e dotato di maggiore grano salis.
White Chocolate viene girato ai Grizzlies di Vancouver, prima che l’intero baraccone trovi una nuova casa ma non un nuovo nome a Memphis. L’intero pastrocchio è barcollante tanto quanto le probabilità di incontrare un Ursus Arctos Horribilis (il Grizzly, per l’appunto) nella contea di Shelby, Tennessee e i Grizzlies si imbarcano in una crociata che conosce molte più sconfitte che vittorie. Nella stagione 2001-2002 Williams fa registrare i suoi numeri migliori di sempre, con una quindicina di punti e otto assist ad allacciata, che gli valgono oltre al ruolo di playmaker titolare anche lo scettro di vicecapitano del vapore dietro ad un ventunenne Gasol. Viva España, ma con moderazione.
La vita in quel del Tennessee procede placida, sino a quando a coach Sidney Lowe succede, a metà della stagione successiva Hubie Brown, momentaneamente impiegato da un network nazionale come commentatore della stagione NBA. Brown, da cronista, non ha mai fatto mistero di non gradire la cioccolata bianca, definendolo un giocatore inconcludente che nessun allenatore con un minimo di obiettivi vorrebbe trovarsi attorno. Se la relazione con il coach non parte esattamente sotto gli astri più lucenti, ancora peggiore è il rapporto del playmaker con Brendan Brown, figlio dell’allenatore e nuovo assistant coach dei Grizzlies. Fra Brown Jr. e Williams gli alterchi sono frequenti in campo e fuori e costano a Giasone lunghe sedute in panchina durante il resto della stagione. Il coperchio viene definitivamente tolto dal pentolone il 7 novembre, in una trasferta a Dallas, quando davanti alle televisioni di mezzo paese, Williams si mette ad urlare improperi contro Brown padre e figlio. L’arrivo di Mike Fratello al posto di Brown, un altro con cui la conversazione non è di stampo Beckettsiano, segnarono definitivamente la fine di Giasone nella città di Elvis e B.B. King.
Miami è la penultima destinazione di una carriera con alti spettacolari e bassi da centomila leghe sotto i mari. Nella città della Florida Williams gioca da esperto comprimario: ormai è un giocatore veterano per età e per ruolo. A South Beach, nel 2006, vincerà anche un titolo, al fianco di leggende ben più titolate come O’Neal, Wade, Payton e Walker, mettendo in tasca una soddisfazione che non molti nella NBA possono dire di avere conquistato. Il suo gioco è cambiato: è più concreto, meno flashy come direbbero quelli per cui l’italiano non è abbastanza, molto più adatto alle richieste di una squadra tanto da anello quanto assolutamente folle. L’immagine che farà la storia, quell’anno, viene ritratta alla fine delle Finali NBA vinte da Miami 4-2 contro i Dallas Mavericks: l’allora NBA Commissioner David Stern si avvicina a Dwayne Wade per consegnargli il trofeo di MVP, O’Neal prende il trofeo dalla mani di Stern dicendo “Faccio io, Dave” e lo consegna ad un imbarazzato quanto confuso Wade, che accoglie il premi con la faccia che si fa alla propria festa di compleanno quando i parenti iniziano a cantare “Perchè è un bravo ragazzo”. Un soffio, e le candele sono spente.
Se all’ombra delle palme la stagione regolare è assolutamente solida, JWill si rivela fondamentale per il backcourt di Miami sopratutto nei playoff, aprendo Gara 1 della serie con Chicago con 17 punti e doppia cifra di assist e proseguendo con numeri di tutto rispetto sia nella serie contro Detroit che nella finale contro i Dallas Mavericks. Con il buon rendimento cresce il minutaggio e la fiducia sul campo fino alle Finali; dopo due partite a dir poco oscene giocate dagli Heat in casa di Dallas, il team di Pat Riley inanella 4 vittorie consecutive. Per Miami è il primo titolo, per Williams il risultato più alto di una carriera, ottenuto dopo un anno di grande crescita.
I festeggiamenti a base di spumante, sorrisi e cuori gonfi di gioia per le strade che costeggiano Flamingo Park sono -un’altra volta- una candela mendace che ha il suo punto più buio proprio accanto alla fiamma. Le due stagioni -disastrose- che seguono sono di ricostruzione completa per la squadra di South Beach, un cantiere aperto per necessità di intenti di progetto e di età. Fuori dalla palestra intanto, la gravidanza della moglie di Williams, Denika Kisty (un ex atleta della squadra di Atletica dei Florida Gators) in attesa dal terzo figlio, viene compromessa da una patologia seria e di cui i medici dello stato del Sud capiscono poco o nulla, costringendo la famiglia a lunghi mesi di ospedale e professionisti. Al termine dell’annata 2007-2008 Williams dichiara ufficialmente il ritiro dal basket. Tornerà un anno dopo, nel 2009-2010, nella stessa Florida e nell’amata Orlando, dopo una vicenda travagliata di contratti con i Los Angeles Clippers -con cui non giocò neppure una partita- e con la Lega e i proprietari, che ne osteggiarono il rientro nell’NBA utilizzando una formula che suonava molto come “Questo Campionato non è un albergo”. O qualcosa del genere.
La stagione ad Orlando dietro Jameer Nelson è tutto fuorché il meraviglioso canto del cigno delle fiabe, e la carriera NBA di uno dei giocatori termina in punta di piedi, come il tramonto incolore di un nuvoloso pomeriggio di fine ottobre.
Uscendo dai bizantinismi, comprendere le ragioni di un esteta della pallacanestro -cosa che certamente era Jason Williams– è stato tanto complicato per il pubblico quanto per i più scafati degli addetti ai lavori, che puntualmente dovevano soppesare una sensazionale macchina da highlight ed un cospicuo fatturato di palloni mandati in tribuna nei momenti clou. Ogni passaggio dietro la schiena riuscito faceva vendere una maglietta, ma ogni no look finito in mano agli avversari poteva costare una partita.
Senza ombra di dubbio alcuno, il 55 dei Kings ha contribuito, insieme a tanti altri esponenti del Gioco dei primi 2000 ad una trasformazione dell’NBA e di tutto il basket da semplice (si perdoni l’iperbole) pratica sportiva a manifestazione quasi artistica. La palla a spicchi diventa danza, esercizio di stile certamente fine a sé stesso ma al contempo anche straordinario linguaggio e forma d’espressione. Certamente, sarebbe sbagliato asserire che prima di quegli anni non vi fosse attenzione al bel gioco e allo showtime, ma altresì è fuori discussione che per la generazione nata fra il 1980 e il 1990, Jason Williams e più iperbolicamente tutto quel movimento di spettacolarizzazione della pallacanestro celebrata ad esempio dagli And1 Mix Tapes, siano stati una miscela insostituibile di ispirazione e ammaliamento.
Perché c’è qualcosa di inspiegabilmente meraviglioso nel riuscire nel modo più difficile possibile a fare una cosa in realtà estremamente semplice. Ed è qualcosa che chi non ha mai giocato non potrà mai capire, perchè la ragione pura e semplice non capisce come si possano barattare dieci palle perse con quell’unico, splendido passaggio dietro la testa in contropiede. Ed eppure è qualcosa che tutti noi, con fini più o meno miseri, abbiamo tentato di fare ai campetti, in allenamento o in campionato, mentre stuoli di allenatori ci imploravano di passarla a due mani dal petto e vedere due punti in più sul tabellone. Ci sono solo due scuole di pensiero, e gli alunni dell’una e dell’altra difficilmente fanno ricreazione insieme.
Se si intende il Gioco come tale, anteponendo il mezzo al fine, il bello al buono, il divertimento al risultato, allora Jason Williams è stato uno dei più grandi interpreti di quest’arte. Se invece si concepisce il basket solo come espressione ultima dell’efficacia, e si misurano i suoi risultati in numeri e percentuali, allora non è stato altro che un botto, un’esplosione nella polvere, il rimbombo di rumore bianco fine a se stesso.